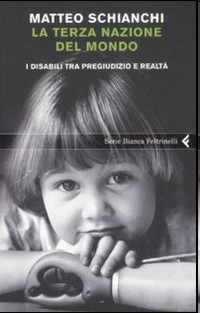
Matteo Schianchi
La terza nazione del mondo
I disabili tra pregiudizio e realtà
Feltrinelli 2009
Pag. 176, Euro 14
In breve
La vicenda Pistorius ha mostrato a tutti che gli effetti negativi
della disabilità possono essere contenuti, ma la realtà quotidiana del
disabile è ancora un percorso a ostacoli, fatto di barriere fisiche, di
pregiudizi psichici, di sguardi pieni di rifiuto.
Il libro
Sono 650 milioni i disabili nel mondo, oltre il 10 per cento della
popolazione globale. Tutti insieme popolerebbero la terza nazione del
mondo dopo Cina e India. In Italia, sono circa 6 milioni, la seconda regione
dopo la Lombardia. Sono le vittime di malattie congenite o acquisite,
traumi psichici, incidenti sul lavoro e stradali, tumori.
L’handicap non solo coinvolge molte persone, ma riguarda tutti poiché
le sue cause stanno nei rischi, nelle fatalità, nelle casualità cui sono
soggette le nostre esistenze. Proprio perché la temiamo, rifiutiamo la
disabilità, la sua vista ci disturba e ci inquieta. L’handicap è un trauma
che sconvolge i corpi, le soggettività, le relazioni degli individui e
del mondo circostante. L’handicap è lutto della perdita della “normalità”,
non una menomazione, ma una specifica condizione umana.
Ma non esiste handicap senza sguardo sull’handicap. Questo sguardo è pieno
di rifiuto, pregiudizi, pietismo provati dai “normali” sui disabili e
dai disabili su se stessi: qui si creano e si alimentano il rifiuto e
l’emarginazione. Uno sguardo stigmatizzante che in realtà ha profonde
radici psicologiche e culturali.
Lo stato sociale è ancora insufficiente, nella prevenzione e nelle risposte
alle forme di handicap, e dovrebbe rifarsi alla recente dichiarazione
Onu dei diritti dei disabili, non ancora ratificata dall’Italia. Le politiche
sono incentrate sull’assistenzialismo, ma hanno buchi strutturali che
fanno dell’integrazione una chimera: barriere architettoniche, risorse
insufficienti, leggi parzialmente applicate, nessuna fornitura di strumenti
psicologici per affrontare il trauma. Questi deficit contribuiscono a
sommergere i disabili nelle difficoltà quotidiane, nelle solitudini, nelle
forme di povertà, in vite completamente sacrificate all’handicap.
Approfondimento
Indice
Introduzione
Forse non tutti sanno che...; Ma tutti sanno che...; Non c’è handicap
senza sguardo sull’handicap; Risposte inadeguate; La soluzione tecnologica
1. Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare
Pistorius; Oltre Pistorius; Di cosa è capace la tecnologia; Oltre il
funzionamento tecnologico
2. La fatica di essere disabili
In un vicolo cieco; Slancio vitale; Dov’è il mio corpo?; La colpa; Quando
nasce un figlio disabile; I disabili cattivi
3. Dis-integrati
Sulla strada; Stigma; Amarsi un po’; Alcune dimensioni della dis-integrazione
4. Tira fuori il mostro che c’è in te
Perturbante; Mostri
5. La mostra delle atrocità
Compatire; Il cinema
6. Prigionieri della civiltà.
Una storia per sommi capi della disabilità:
Nel mondo greco-romano; Nel mondo medioevale; Nel mondo moderno; Rieducare;
La Rivoluzione industriale; “Forgiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia”;
Drammatico ritorno al passato: i campi di sterminio nazisti; Lo stato
sociale; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità
7. Effetto collaterale e risposte insufficienti
Effetto collaterale; Risposte insufficienti; Contare per fare; Le politiche
assistenzialiste; Ratificare la Convenzione Onu
8. La barriera culturale
Non se ne parla mai!; Disabili nella rete; Arrivano i grandi media; Superdisabili
e superhandicappati; Non c’è più religione; Arte e handicap
9. Umano, troppo umano
La nuova carne; Consumatori; Quale integrazione?
Sitografia
Note
I disabili tra pregiudizio e realtà
Matteo Schianchi presenta La terza nazione del mondo
A cura della redazione di www.feltrinelli.it
Come mai prendi come riferimento il caso Pistorius?
Il caso Pistorius, l’atleta sudafricano che voleva partecipare con le
sue protesi alle olimpiadi dei normali, ha reso evidente una cosa molto
importante per il mondo della disabilità, cioè che la tecnologia è uno
degli strumenti migliori per superare i limiti imposti dall’handicap.
Proprio per questo la questione tecnologica è molto presente nel mio libro.
Vogliamo ricordare cosa successe? Fu ammesso alle Olimpiadi?
Nel caso Pistorius in un primo momento l’uso delle protesi è stato considerato
doping tecnologico. Dopo il suo ricorso la commissione ha accettato la
sua partecipazione con quelle specifiche protesi. Pistorius non ha poi
partecipato perché non è riuscito ad ottenere il tempo di qualifica. Volevano
dargli una wild-card ma lui l’ha rifiutata. Paradossalmente questo crea
almeno due tipi di problemi. Il primo è che da un punto di vista dell’immagine,
se Pistorius avesse partecipato, almeno per 40 secondi un disabile avrebbe
partecipato per la prima volta alle olimpiadi dei normodotati. Il secondo
è che la sentenza della corte arbitrale vale solo per Pistorius e solo
per quel tipo di protesi. Se Pistorius volesse partecipare alle prossime
olimpiadi con delle protesi anche minimamente modificate dovrebbe ripetere
tutto l’iter.
Nel mondo della disabilità, c'è stata identificazione con Pistorius?
C’è stato sicuramente un forte elemento di identificazione. Pistorius
anche con la sua presenza nei media, ha dato dignità alla questione della
disabilità, per cui è inevitabile che ci fosse un fenomeno di identificazione,
per almeno due ragioni: una legata allo sport, al fatto di correre con
i normodotati, l’altra legata al fatto che Pistorius è diventato una figura
mediatica.
Perché la tecnologia ha un ruolo così importante?
Perché la questione tecnologica per l’handicap fisico è il migliore strumento
per l’integrazione. In questo libro si parla di Pistorius ma si parla
delle tecnologie che sono a favore di persone con handicap molto gravi.
Oggi esistono delle tecnologie che permettono di comandare delle carrozzine,
per esempio per persone tetraplegiche, solo con la forza del pensiero.
Ù
Perché non viene distribuita la tecnologia a chi ne ha bisogno?
Riguardo all’uso della tecnologia c’è da dire che una maggiore fruibilità
degli ausili tecnologici è parzialmente bloccato dal fatto che masncano
i necessari finanziamenti pubblici per arti artificiali, carrozzine superleggere,
tutti strumenti utili all’integrazione del disabile. Ma per l’integrazione
la tecnologia da sola non basta. Come dice Galimberti, la tecnologia funziona,
ma per costruire senso è necessario superare uno dei grandi problemi a
cui sono soggette le persone disabili che è la stigmatizzazione e l’esclusione
sociale
Qual è la dimensione del pregiudizio per le persone disabili?
Il pregiudizio è una dimensione fondamentale, in senso negativo, per la
persona disabile, poiché appena il disabile si presenta sulla scena pubblica,
gli sguardi e i comportamenti stigmatizzano immediatamente la sua persona.
Questo pregiudizio riguarda spesso anche il disabile verso se stesso.
È un pregiudizio legato al limite, al fatto che la persona disabile non
è concepita interamente e completamente umana. È un problema legato all’inferiorità
della persona disabile; tutte queste dimensioni, che hanno profonde radici
psicologiche e una storia, ugualmente profonda, che risale alle civiltà
antiche per arrivare fino ai giorni nostri, è particolarmente pregnante.
È proprio da qui, dal pregiudizio, che si formano nella concretezza della
vita delle persone l’emarginazione e l’esclusione sociale, sul lavoro,
nei sentimenti, nelle relazioni sociali e così via. È una vera e propria
barriera culturale
Da dove deriva la parola handicap?
Deriva dall’inglese hand in cap che era legata a due giochi. Uno
è un gioco d’azzardo che potremmo tradurre in “mettere le mani nel cappello”
e l’altro invece era legato all’equitazione ed era il limite imposto ai
cavalli più forti affinché pareggiassero le possibilità dei competitori.
Nel lubro uso spesso la parola handicap ma bandisco completamente la parola
handicappato che secondo me oggi non ha più ragione di esistere, anzi
è un termine completamente offensivo per chi vive questa realtà. Uso come
categoria il termine disabile riferito a persona, quindi come aggettivo
e non come sostantivoe che preferisco a termini un po’ buonisti come “diversamente
abili” “diversabili” o “altrimenti abili”. Disabile secondo me è un termine
che identifica abbastanza bene la realtà senza stigmatizzare i soggetti
come invece avviene con la parola handicappato che è un termine che stigmatizza
in quanto definisce la parte con il tutto.
Qual è l'impatto dell'handicap nei soggetti che ne sono colpiti
La dimensione della disabilità coinvolge il soggetto in molti aspetti
che vanno dalla percezione di sé, al rapporto con il proprio corpo, al
rapporto con il futuro cioè la possibilità di potersi vedere in un futuro
nonostante la disabilità. Sono numerose le dimensioni psicologiche che
coinvolgono non solo il soggetto ma anche chi gli è vicino. Tant’è che
per esperienza posso dire che le famiglie in cui c’è un soggetto disabile,
sono le famiglie in cui si parla meno di disabilità, perché la disabilità
struttura l’intero universo familiare. Ritengo che è necessario fornire
al soggetto disabile e al suo universo familiare gli strumenti idonei
a superare il trauma della disabilità proprio per evitare che questa strutturi
il soggetto e la vita del nucleo familiare. In questo senso il fatto che
i disabili possano usufruire, come sostiene il dispositivo di legge che
governa la disabilità in Italia, possano usufruire di sostegno psicologico
per poter superare il lutto della perdita della normalità legato all’handicap
è fondamentale. Nella realtà, però, questa dimensione è disattesa dalle
politiche pubbliche.
Nel tuo libro parli provocatoriamente di mostri, dei freaks di Tod
Browning, dei personaggi di Ballard e Cronenberg. Perché?
La questione dei “mostri” è storicamente legata alla disabilità. Sin dall’antichita
greca e romana i bambini nati deformi venivano uccisi o portati al di
fuori delle città. Sin da allora il problema delle disabilità è legato
alla deviazione dalla norma. In questo senso evoca la questione del mostro.
Questa diventa fenomeno pubblico e spettacolare sin dal 700 , ma è soprattutto
nell’800 con i “fenomeni da baraccone”. Nel capitolo intitolato “La mostra
delle atrocità” proprio dei “fenomeni da baraccone”, il più famoso dei
quali è l’uomo elefante, ma ci sono anche italiani, come i fratelli Tocci.
Nella metà dell’800 negli Stati Uniti viene inaugurato l’American Museum,
una sorta di antenato di Disneyland dove tra i vari spettacoli che venivano
proposti c’era l’esibizione di questi fenomeni da baraccone. Non si trattava
solo di presentare queste stranezze umane, ma c’era anche una dimensione
spettacolare - la nana che sposava il gigante, l’uomo-scheletro che sposava
la donna più grassa del mondo. Questo per creare un effetto burlesco e,
nello stesso tempo, per collocare la dimensione di questi mostri all’interno
del mondo dello spettacolo. Tutto questo creava negli spettatori un effetto
di estraniazione che permetteva loro di sentirsi rassicurati della propria
normalità,
Perché questi autori ti sembrano così importanti?
Il movimento cyberpunk in generale e la filmografia di Cronemberg in particolare
a mio parere sono le espressioni artistiche più interessanti per definire
la dimensione tecnologica dell’uomo contemporaneo. C’è un rapporto tra
il mio libro e Crash di Cronemberg, il film tratto dal romanzo
di Ballard, così come Videodrome, dove si parla di “nuova carne”,
la “carne tecnologica” strettamente interconnessa alla carne umana.
Quando Crash uscì in Inghilterra in una versione parzialmente censurata
mi colpì molto il fatto che associazioni di disabili avevano protestato
e chiesto che il film fosse proiettato nella sua versione integrale, perché
per la prima volta si mostrava la questione della sessualità legata alla
disabilità in un modo né morboso né pietistico. Per cui c’era una dimensione
fortemente estetizzante ma anche fortemente problematica. Sia al film
che al romanzo sono legate molte dimensioni che non sono solo legate alla
sessualità ma al più ampio rapporto uomo-macchina, che nella dimensione
della protesi per le persone disabili è fortemente caratterizzante. Il
mio interesse per questa dimensione è legato al fatto che illegame tra
corpo e tecnologia è strettamente connesso alla disabilità. Rispetto alla
persona disabile, la tecnologia non è solo funzionale ma modella il corpo
cosi come in Cronemberg la tecnologia modella i soggetti, e , nel caso
di Crash, anche la sessualità. In questo senso la tecnologia non
si limita ad aiutare il soggetto disabile a superare il limite, ma modella
l’identità del soggetto. Se pensiamo a protesi o a carrozzelle che si
muovono sol pensando di farlo, lì la tecnologia è completamente all’interno
del soggetto. In questa situazione il corpo non esiste senza tecnologia
cosi come la tecnologia non esiste senza corpo perché per funzionare ha
bisogno del corpo.
Ma come si svolge la vita di un disabile che non sia privilegiato come
Pistorius?
Nella realtà, mediamente le persone disabili vivono molto peggio di Pistorius,
per fenomeni legati all’esclusione e alla marginalizzazione sociale. Ch
vuol dire impossibilità di accedere alle dimensioni reali del vivere –
relazioni, amicizie, sentimenti, sessualità, istruzione, lavoro ecc –
se guardiamo gli indicatori, le persone disabili rispetto a queste dimensioni
hanno sempre dei parametri particolarmente gravi.
Cosa manca in termini culturali per affrontare l'handicap?
Questa è una dimensione che riguarda molto la realtà sociale. Dal mio
punto di vista mancano, oltre ai supporti materiali e psicologici di cui
abbiamo parlato prima, i linguaggi per affrontare tali situazioni. In
questo libro si parla spesso di cinema, il cinema è forse l’arte che,
insieme alla letteratura, più spesso ha affrontato la questione della
disabilità. Altrettanto spesso, però, si tratta di occasioni mancate:
la disabilità diventa una dimensione estetica o metafora del vivere, delle
debolezze umane. Il problema è che quando si parla di disabilità, e questo
anche nei media, l’handicap non viene mostrato e riconosciuto nel suo
radicamento corporale e psichico.
A chi è rivolto questo libro?
A un pubblico vasto, e questo per due ragioni. La prima è che mai come
nelle società contemporanee la disabilità riguarda davvero tutti, perché
i rischi ai quali siamo quotidianamente sottoposti fanno sì che la disabilità
sia un fenomeno molto trasversale e molto presente. Basti pensare che
ogni anno solo in Italia vengono “create” ex novo cinquantamila nuove
persone disabili dagli incidenti sul lavoro, incidenti stradali, malattie,
i banali tuffi in piscina o al mare… C’è una casistica molto vasta di
cause di disabilità che ci rendono tutti esposti a questo rischio.
Il secondo è che lo sguardo che abbiamo, individualmente e collettivamente,
sulla disabilità contribuisce a creare e far sedimentare i pregiudizi.
Per questo il libro non e rivolto solo alle persone disabili e alle loro
famiglie o a chi si occupa di disabilità.
Rispetto a qualche decennio fa non ti sembra che comunque la situazione
sia migliorata?
Notevolmente. Fenomeni come la vergogna per il figlio disabile o del disabile
tenuto a casa si sta sicuramente superand, anche se non è un dato ancora
acquisito, poiché i fenomeni di chiusura all’interno delle case delle
persone disabili, la vergogna del farsi vedere sulla scena pubblica sono
ancora piuttosto elevate. Non ho mai visto in giro per il centro di Milano
tanti disabili come a ferragosto. L’impressione che ne ho avuto è che
si aspetti che tutti siano in vacanza per poter uscire. Quindi la vergogna
del mostrarsi è un fenomeno ancora molto presente. In molte inchieste
sii dice che le persone disabili sono quelle che stanno di più in famiglia,
e in questo si celebra il mito italiano della famiglia che si fa carico
dei suoi disabili. In realtà il problema è un altro: i disabili stanno
in famiglia per diverse ragioni. Innanzitutto perché spesso non hanno
la possibilità di farsi una loro famiglia, e poi rispetto a un mondo esterno
che li esclude su sentono più protetti in famiglia.