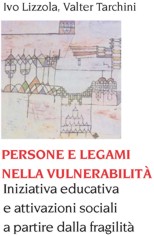 Persone
e legami nella vulnerabilità.
Persone
e legami nella vulnerabilità.
Iniziativa educativa e attivazioni sociali a partire dalla fragilità
Ivo Lizzola, Valter Tarchini
Prezzo: € 15
Pagine: 240
UNICOPLI, Milano, 2006
AUTORI
Ivo Lizzola è docente associato di Pedagogia sociale e di Pedagogia
della marginalità e della devianza presso l’Università degli Studi di
Bergamo. La sua ricerca e l’attività di consulenza e di formazione nei
Servizi educativi e sociosanitari hanno riguardato lo sviluppo delle politiche
sociali (con attenzione ai giovani e alle marginalità) e più recentemente
i temi della cura, delle vulnerabilità e della bioetica.
Valter Tarchini, psicosociologo, collabora con lo Studio Aps di
Milano e con il Centro formazione lavoro “A. Grandi” di Bergamo. Gli ambiti
privilegiati sono relativi allo sviluppo d’innovazioni organizzative,
alla promozione d’integrazioni tra Servizi e soggetti sociali in relazione
a oggetti di lavoro complessi, al sostegno all’assunzione di una prospettiva
progettuale nell’operare professionale quotidiano.
OPERA
La pedagogia sociale, con il suo sguardo e le sue pratiche, incrocia sempre
più oggi le dimensioni dell’etica e dell’antropologia, e si scopre necessariamente
portatrice di dimensioni bio-politiche e civili. Questa raccolta di saggi
si muove in tre direzioni per: cogliere i modi con cui si strutturano
alcune “situazioni etiche” attorno alle esperienze di estrema vulnerabilità
e fragilità; raccogliere alcune forme educative e sociali di resistenza
al male (di riconoscimento, di ricomposizione, di riconciliazione, di
perdono), indagandone fondamenti e tratti; presentare concrete esperienze
sociali, riprogettazioni territoriali e articolazioni di servizi rese
possibili da un intreccio di competenze professionali, coscienza civile,
senso dell’intrapresa, moventi etici. Sullo sfondo emergono grandi questioni
che, tutte, ruotano attorno alle difficoltà presenti nel ricomporre la
vita comune, nell’assumere la vulnerabilità come condizione comune e come
luogo originario della cura e della responsabilità, nel sostenere un riconoscimento
pubblico del dolore e della sofferenza.
Indice
Premessa
Introduzione: Tempi diversi
bussano alla porta, di Ivo Lizzola
Parte prima
EDUCAZIONE E LEGAMI NELLA PROVA,
di Ivo Lizzola
1. Vicinanza, legami e marginalità sociale
2. La vulnerabilità e la cura come situazione etica
3. I graffiti e le parole
4. Liberi, precari, incerti
5. Quando il corpo diventa limite
6. Educazione, colpa e riscatto
Bibliografia
Parte seconda
GENERARE LEGAMI PRODURRE SOCIETÀ,
di Valter Tarchini
1. Dimensioni professionali e organizzative in servizi rivolti alla persone
disabili
2. Disabilità e territorio: spazi per una progettualità
sociale
3. Minori e famiglie straniere: progettualità sociale nel territorio
4. Logiche d'azione nei servizi rivolti alla prima infanzia
5. Transizioni possibili: storie di giovani verso percorsi di formazione
6. Riferimenti e stimoli attorno alla valutazione nei servizi
Bibliografia
Introduzione
Tempi diversi bussano alla porta
Ivo Lizzola
Nel tempo della globalizzazione, dell’interdipendenza, delle migrazioni
continue prendono sempre più forma processi di scomposizione, di
frammentazione, di scontro e di esclusione. Questi interessano il territorio
sociale, le forme e le regole della convivenza, il sistema dei diritti.
Nondimeno toccano e attraversano le identità e le biografie delle
persone.
Prendono forza culture e pratiche (educative e sociali) della esclusione,
della negazione, della selezione, del distanziamento. Diventa molto più
difficile sostenere il confronto con la diversità, con la pressione
della vicinanza, con la fragilità e la vulnerabilità (propria
e altrui), con la cura. E, più radicalmente, con la dimensione
del male. Siamo troppo vicini, e più fragili: c’è
un guadagno?
La pedagogia sociale con il suo sguardo e le sue pratiche incrocia dimensioni
dell’etica e dell’antropologia e si scopre necessariamente
portatrice di dimensioni biopolitiche e civili.
Questa raccolta di saggi si muove in tre direzioni:
– cogliere i modi con cui si strutturano alcune “situazioni
etiche” attorno alle esperienze di estrema vulnerabilità
e fragilità e i loro caratteri;
– raccogliere alcune forme educative e sociali di resistenza al
male (di riconoscimento, di ricomposizione, di riconciliazione, di perdono),
per indagarne fondamenti e tratti;
– presentare concrete esperienze sociali, riprogettazioni territoriali
e articolazioni di servizi rese possibili da un intreccio di competenze
professionali, coscienza civile, senso dell’intrapresa, moventi
etici.
Sullo sfondo emergono tre grandi questioni che, tutte, ruotano attorno
alla fatica del ricomporre la vita comune, del dispiegare l’azione
nello spazio di visibilità pubblica – per dirla con Hannah
Arendt. Fatica dell’assumere la vulnerabilità come condizione
comune e come luogo originario nel quale si dà la cura e la responsabilità.
Fatica del sostenere un riconoscimento pubblico del dolore e della sofferenza.
Una delle questioni da approfondire, ineludibile, è l’impatto
dell’esperienza della diversità sul lavoro sociale. La diversità
altrui, una volta lontana, si è fatta così prossima a noi,
nei nostri tempi di vita. La diversità nostra entra nelle vite,
nei destini degli altri, lontani vicini. Sentiamo la diversità,
nostra e altrui, attraversarci, creando inquietudini e smarrimenti. L’estrema
vicinanza produce ricerca di sicurezza degli uni contro gli altri, fa
elevare barriere interiori ed esteriori. Insieme orienta a cogliere nell’altro
prevalentemente il male e a trarre da (tollerare in) noi ciò che
consideravamo male, sopraffazione, ingiustizia.
La diversità che ci attraversa nell’estrema vicinanza è
una prova, obbliga a fare i conti con ciò che portiamo nel cuore,
anche con il fondo oscuro di timore e distruttività che teniamo
in noi. E che avvertiamo nel vicino
È una prova dura, chiede un continuo lavoro su di sé, e
chiede una continua trasformazione dei conflitti. Non basta, nell’estrema
vicinanza, il riconoscimento formale dell’eguaglianza, o il richiamo
del diritto.
Una seconda questione, radicale, si pone per la nuova forza che tornano
ad assumere la prova e la percezione del male e dell’ingiustizia
(sentiti dal lato freddo del cinismo, del calcolo lucido del male arrecato;
o da quello dell’avvelenamento dell’istinto di morte, della
sua forza corrosiva). È la questione che potremmo definire “della
colpa e del riscatto” che emerge nel cuore della relazione educativa,
come della relazione sociale. Relazioni subito portatrici di violenza
e distanziamento, oppure di riconoscimento e ricomposizione.
In un presente in cui storie e memorie, di singoli e comunità,
fanno i conti con “l’imperdonabile” e con il disprezzo,
l’estrema vicinanza e la diversità pongono il lavoro sociale
di fronte a tensioni e a dinamiche sacrificali. Nelle trame di ricomposizione
e riconciliazione sociale il perdono emerge come dirompente logica costitutiva
dell’esperienza umana, logica che riapre continuamente le questioni
della giustizia, del legame sociale, della memoria
Si può cercare attorno alla possibilità, nei progetti sociali
come nelle realtà lacerate del conflitto: di lavorare sul peso
del risentimento e del rancore, di confrontarsi con la logica della purificazione
e della restituzione del male subìto, di promuovere resistenze
e riconciliazioni.
Una terza questione è legata al fronteggiamento del male (in questo caso della malattia, della mortalità, della finitudine) con la cura, in un contesto nel quale le tecnologie e la ricerca biomedica confondono e ridisegnano obiettivi, intenzionalità, diritti e responsabilità sulle “scene della cura”. Vedendo emergere, proprio su queste ultime, esercizi di appropriazione/espropriazione, di estraneazione o di reclusione. Ma anche mostrando come i luoghi e le storie di cura si ri-stabiliscono come luoghi dell’interumano per scambi e “reciprocità tra insostituibili”, forme di una prossimità “al limite dell’impossibile” (per usare espressioni di Paul Ricoeur ed Emmanuel Lévinas). Forza e debolezza, esistenziale e professionale, si giocano in una circolarità di diversità continuamente trascese e superate.
Nelle pagine di questo testo spesso s’incontrano richiami a storie,
territorio, relazioni, progetto, legame, sostegno, diritto,… sono
parole che hanno un senso, che esprimono una tonalità umana, uno
spazio di significatività tra le generazioni se esiste una dimensione
politica, una tessitura di legami, una pratica che istituisca le forme
della convivenza sociale. Dicono tutt’altro se i rapporti interpersonali
e sociali, se le prospettive dei singoli e dei soggetti sociali, se le
forme di servizio e i comportamenti sono privatizzati, o privatistici.
Vincenzo Bonandrini, raffinato sociologo e formatore, ripeteva che comunità
è ciò che è comune tra quelle donne e quegli uomini:
ciò che è fatto in comune, preso in una comune e reciproca
cura (Bonandrini, 1996). Costruire uno “spazio comune” è,
allora, la dimensione fondativa di una progettazione sociale che è
salvaguardia d’identità e di buone ricerche di senso, di
vocazioni e di attese di futuro e di giustizia dentro la convivenza.
Nella nostra convivenza diverse attese si manifestano, a volte restano
eluse, o si scontrano con le ragioni della forza o del mercato. Sono come
tempi diversi che bussano alla porta.
Ci sono tempi, nella vita delle persone, che attendono la cura, e tempi
di persone che attendono alla cura: tempi, gli uni e gli altri, concentrati
su un presente carico di fragilità e, insieme, di vita. A volte
è un presente denso, pesante e ripiegato, difficile da riaprire
per il peso della dipendenza e della solitudine. Oppure è un tempo
presente nel quale viene colta e ascoltata l’attesa di rispetto,
di attenzione a una dignità umana tanto più da riconoscere,
con gesti e parole, quanto più pare compromessa e infragilita.
E questo presente che pare rattrappito diviene, allora, luogo d’incontro,
luogo di delicati progetti. In essi saperi e vissuti è come se
si curvassero sulla vita (quella nascente, quella ferita, quella morente).
Perché chi è più debole non resti solo.
Ci sono tempi che attendono novità e futuro, nelle scelte della
vita che cresce di giovani e giovanissimi. Nella tensione a dovere e volere
lasciare, e a volere e dovere provarsi in nuova autonomia e in nuove relazioni.
Spesso sono passaggi al futuro che si vivono nell’angoscia sottile,
temendo di non farcela, di non trovare appoggi, di non godere di fiducia.
I bambini, gli adolescenti hanno bisogno di sentire su di sé un’attesa:
al gioco delle loro novità, delle loro sensibilità ed energie,
dei loro pensieri. Essere chiamati in responsabilità, essere ascoltati,
essere di qualcuno. Che ti sostiene, che ha bisogno di te e ti dà
fiducia. Con progetti aperti ai sogni di futuro. Altrimenti la sospensione
sul futuro può non essere sostenibile. E questo vale anche per
tante donne e uomini che devono ricominciare dopo una frattura nella vita
e nelle relazioni.
Perché chi è sospeso non resti solo.
Ci sono tempi della consegna, e del congedo. In essi le donne e gli uomini,
spesso, più che il calcolo del raccolto cercano segni di una buona
semina (delle speranze, delle fatiche, dell’attesa di giustizia
e di serenità…). Vorrebbero sentire l’ascolto e un
buon uso della memoria: sentono il morso della disattenzione, della dimenticanza.
Magari ben assistita, in spazi privati invisibili o in ricoveri nei quali
è quanto meno rara l’attesa di un racconto, di una buona
conservazione delle speranze, di una consegna. Mentre possono essere ben
valorizzati in legami sociali e progetti con il gusto della fedeltà
e della dimensione della memoria.
Perché chi chiude una parabola non sia lasciato solo.
L’attesa è al cuore dei legami tra donne e uomini: sentire
su di sé un’attesa è richiamo al legame e alla responsabilità,
è valorizzazione del nome d’ognuno, della specificità
d’ognuno nel dare sostanza alle relazioni. È sopportazione
dei limiti e della vulnerabilità, e possibile riabilitazione.
Senza attese, senza reciproche attese tra le donne e gli uomini, tra le
generazioni, non c’è che legame sociale arido, fondato sulla
forza e l’autoaffermazione. E non c’è buona progettazione
sociale. Resta una convivenza fatta solo di rapporti di forza e di scambi
tra soggetti dal diritto acquisito, preoccupati di difendersi, di affermarsi,
di tenere a distanza.
Senza attese resta la solitudine d’individui segnati dal mito dell’autogenerazione
e dell’autosufficienza (individui che “si fanno da soli”),
dimentichi che tutti siamo anzitutto figli. Che siamo affidati gli uni
agli altri, e per questo siamo chiamati a essere responsabilmente affidabili.
I testi qui raccolti non nascono solo da un coltivato e complesso rapporto
tra azione sociale e pensiero, costruzione del pensiero, esperienza conoscitiva
(azione e pensiero vissuti e costruiti sempre come luoghi di relazione
responsabile). Mostrano anche una serie di contesti di convivenza (a maggiore
o minore densità istituita), di servizio, di progettazione sociale
nei quali la tessitura di responsabilità assunte si è realizzata
nella deposizione del desiderio di potere su tutto e su tutti.
Dalle relazioni, dalle pratiche, dalle storie organizzative, dai progetti
territoriali di cui si parla in queste pagine emerge con chiarezza che
“agendo s’impara a riflettere” (e non viceversa), quando
la cura, le tecniche e il potere non sono usati per evitare il contatto
con la realtà ma per costruire avvicinamenti responsabili alle
situazioni di vita delle persone.
La conoscenza, allora, evita di essere una “strategia di bonifica”,
di evitamento della complessità della realtà (specie della
realtà umana e sociale) di astrazione e generalizzazione, oppure
di settorialismo specifico (altrettanto astratto).
Evitare le “strategie di bonifica” significa, ad esempio,
evitare una visione oggettivante del mondo: si conosce nella relazione.
Così pure non è possibile alcuna “neutralità
dell’osservatore” se si è tutti presenti in relazioni
interessate e co-responsabili.
Evitare un pensiero che bonifica e un agire che risolve permette di entrare
con più attenzione, e anche con più profondità e
forza, nelle storie delle persone, delle famiglie, dei contesti di vita.
Ascoltando tutte le plurali risonanze che si determinano a partire dalle
azioni che si propongono e si attivano. Spesso inattese e generative.
Facendo esperienza del limite, aprendo luoghi di riflessività sociale,
e permettendo scelte, azioni, organizzazioni.
“Il quotidiano, l’esistenziale, il profondo dell’uomo
e delle sue relazioni” spesso sfuggono alle “certezze di superficie,
nascondono realtà e tesori che la scienza e la tecnica ignorano
perché non sono generalizzabili” (Manara, 1995, p. 97) Così
scriveva Attilio Manara in un testo dedicato a operatori sociali e politici
sottolineando che “ogni profondo capire è interno agli accadimenti
e viene dalle storie”, e che occorre scavare là dove si celano
“forze nascoste”: risorse e capacità di resistenza
e di nuovo inizio, con il respiro di futuro e la fedeltà a lasciti
preziosi.