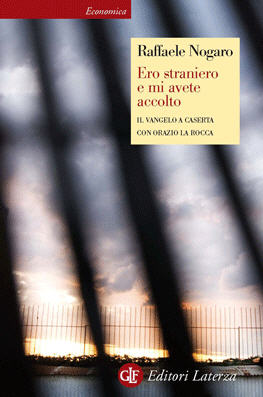
Raffaele Nogaro
Ero straniero e mi avete accolto
Il Vangelo a Caserta
con O. La Rocca
Laterza, 2011
p. 140, Euro 8.50
In breve
«Ho sempre creduto che la Chiesa debba fornire grande testimonianza
di civiltà, e quindi anche di giustizia e di legalità. Da
noi c’è una pratica religiosa anche fervente, ma la vita
cristiana rimane nascosta, senza responsabilità sociale. Io chiedevo
e chiedo una Chiesa dell’impegno sensibile a tutti i problemi d’umanità.»
«Vorrei che la mia Chiesa oggi fosse sempre più una Chiesa
di frontiera, protesa verso i bisogni dell’uomo, non di vertice.
Significa stare in mezzo alla gente comune, non essere chiusa tra quattro
mura, in una curia dorata, inaccessibile ai più, perché
la frontiera è fuori dal tempio. La frontiera – si sa –
è sempre stata un luogo esposto, un confine che sta lì per
essere attraversato e andare verso nuove terre, luoghi a volte sconosciuti.
La frontiera è sempre stata il luogo degli arrivi e delle partenze.
È il luogo dell’imprevisto, dell’inedito. È
il luogo dell’originale. In definitiva, è la meta agognata,
è il luogo dell’uomo sempre nuovo e sempre in attesa di una
patria. È questa la Chiesa di frontiera che io sogno di vedere,
una Chiesa sempre in cammino e, nello stesso tempo, artigiana della pace:
non solo della pace dei cuori, ma anche della pace che passa attraverso
l’azione politica». Vescovo di Sessa Aurunca e poi di Caserta,
Raffaele Nogaro ha reso servizio per 26 anni in una delle terre più
difficili e contraddittorie del nostro paese, la Campania. Con passione,
in queste pagine racconta e al tempo stesso denuncia il suo Sud, senza
tirarsi indietro di fronte ai temi più scottanti, dall’immigrazione
clandestina alla diffusa illegalità, dal recente caos della spazzatura
al dramma del lavoro, assente, nero, precario, dal malgoverno della politica
collusa con la camorra agli errori e ai silenzi (troppi) della Chiesa.
Raffaele Nogaro, friulano di nascita, è stato
nominato vescovo di Sessa Aurunca da Giovanni Paolo II nel 1983 e trasferito
a Caserta nel 1990, dove fino al 2009 ha svolto la sua missione pastorale.
Indice
Introduzione - 1. «Ero straniero e mi avete accolto» - 2.
Una vocazione contrastata - 3. Parroco al Nord, vescovo al Sud - 4. Il
catechismo della legalità - 5. La Chiesa di frontiera e la politica
- 6. Sempre e comunque no alla guerra - 7. Lo scandalo della povertà
- 8. Gli immigrati non sono merce - 9. Come combattere la camorra - 10.
Ambiente e salvaguardia del creato - 11. La Chiesa di Cristo - Epilogo
Sulla croce senza reciprocità - «Amo la mia gente con le
opere di misericordia»
La recensione di Roberto Saviano
Leggi un brano
ORAZIO LA ROCCA Lei ha detto più volte di volere una Chiesa più di frontiera che di Palazzo. Che cosa significa?
RAFFAELE NOGARO «È una scelta di vita che nasce semplicemente da Gesù, che è l’uomo per gli altri per eccellenza. E questo significa che anch’io, apostolo di Cristo, devo essere l’uomo per gli altri. In tutto quello che dico e che faccio, tutti i giorni e per tutta la mia vita. È questa la linfa che ha sempre nutrito la mia esistenza. Purtroppo, sono personalmente convinto che oggi la Chiesa sia fortemente ancorata alla liturgia e alla evangelizzazione, ma sia meno sensibile alla carità, all’amore verso tutti gli uomini. Io sogno, invece, una Chiesa piena di Vangelo, che renda Gesù visibile dovunque e da chiunque. Non a caso, durante il suo pellegrinaggio terreno Gesù parla poco di questioni morali, mentre la sua condotta sembra essere ‘eccessivamente’ misericordiosa. Non insiste mai, nella sua predicazione, sui precetti e sulle ideologie giustificatrici. Presentandosi come ‘Figlio dell’Uomo’ non appare certo come il Dio dei poteri, delle istituzioni di vertice e dei sistemi forti, che creano le vittime e gli sfiduciati, i perdenti e gli esclusi. Gesù sta sempre con coloro che piangono, soffrono, sono schiacciati dalla vita e hanno ‘fame e sete di giustizia’. E io, vescovo, nelle mie scelte pastorali devo sempre cercare di imitarlo con tutte le mie forze».
OLR Sembra che lei non sia molto entusiasta di come l’istituzione ecclesiastica tenti di stare vicino ai bisognosi. Eppure non sono poche le opere di misericordia e di carità per i poveri attivate da organismi promossi dalla Chiesa cattolica. Basti pensare ai missionari che lavorano in Africa, in America Latina, in Asia, in paesi vittime di fame e guerre; come pure le Caritas, i tanti volontari impegnati nelle mense parrocchiali...
RN «Non discuto il bene che, senza ombra di dubbio, c’è in tante realtà ecclesiali. Anzi, sono felice e mi commuovo quando vedo con quanta abnegazione migliaia di volontari, sia nelle grandi che nelle piccole città, si spendano per gli altri, per i più indifesi. Oggi vedo, però, l’avanzare di una Chiesa troppo autoreferenziale che confonde facilmente i suoi fini con i suoi interessi. È un atteggiamento che può essere letto come il tentativo di parte della gerarchia ecclesiastica di indurci a pensare che Dio sia nella Chiesa e, pertanto, che il mondo esista per servire la Chiesa e questa per affermare a ogni costo solo ed esclusivamente se stessa. Invece, Dio è nel mondo e la Chiesa esiste per servire il mondo, creato e amato da Dio, redento e perdonato da Lui.
Questo mondo è il nostro mondo, è quello che Dio ci ha dato da amare come lo ha amato Lui. Non siamo qui per giudicarlo, questo mondo, ma per annunciargli il Vangelo, cioè la salvezza e la felicità. Per Gesù i sabati, i templi, i filatteri [le capsule di cuoio legate con cinghie alla testa e al braccio sinistro che contenevano 4 capitoli della Torah, N.d.R.], i precetti diventano totalmente secondari di fronte al dolore degli uomini. Gesù lascia le curie del potere e va nell’‘orto’ del Getsemani dove egli suda il sangue dei poveri. L’opzione della Chiesa dovrebbe essere ancora il predicare un cristianesimo di sequela, cioè vero, autentico e continuativo, piuttosto che un cristianesimo di consumo, fatto solo di apparenze, di vuoti dogmatismi e di ipocrisie. Non si può pensare che con più praticanti si salvano più uomini. Ecco perché dico, sperando di non esagerare agli occhi di qualche benpensante, che vorrei che la mia Chiesa oggi fosse sempre più una Chiesa di frontiera, protesa verso i bisogni dell’uomo, non di vertice, istituzionalmente lontana. Essere Chiesa di frontiera significa stare più in mezzo alla gente comune che restare chiusa tra quattro mura, in una curia dorata, inaccessibile ai più, perché la frontiera è fuori dal tempio. La frontiera – si sa – è sempre stata un luogo esposto, un confine che sta lì per essere attraversato e andare verso nuove terre, luoghi a volte sconosciuti. La frontiera è sempre stata il luogo degli arrivi e delle partenze. È il luogo dell’imprevisto, dell’inedito. È il luogo dell’originale. In definitiva, è la meta agognata, è il luogo dell’uomo sempre nuovo e sempre in attesa di una patria. Ma la frontiera è anche il luogo di Cristo, perché non si può pensare qualcosa di più urgente e di più precario della capanna della sua nascita a Betlemme, posta anch’essa ai confini, alla frontiera della città, tra la gente semplice, pastori, viandanti. È questa la Chiesa di frontiera che io sogno di vedere, una Chiesa sempre in cammino e, nello stesso tempo, artigiana della pace: non solo della pace dei cuori, ma anche della pace che passa attraverso l’azione politica».
OLR Questo significa che la Chiesa deve anche guardare alla politica? Ce lo può spiegare meglio?
RN «Quando dico che la Chiesa deve guardare anche all’azione politica, dico prima di tutto che deve pregare per la pace, ma non solo. La Chiesa, tra i suoi primari compiti, è chiamata anche a difendere l’uomo dal dominio incontrollato delle istituzioni e delle corporazioni, che rischiano di renderlo puro strumento della loro volontà di potenza. La Chiesa deve, quindi, intervenire per allargare gli ordinamenti democratici che esprimono la sovranità popolare e per rendere sempre attiva la libertà personale. Deve difendere l’uguaglianza tra gli uomini, impedire lo sfruttamento di una classe sociale sull’altra, di un popolo sull’altro e combattere apertamente l’onnipotenza del capitale e del profitto, del capitale e dello sfruttamento. Deve, inoltre, denunciare tutte quelle scelte politiche che procurano la corsa agli armamenti e deve sostenere il disarmo progressivo di tutte le nazioni, a partire da potenze e superpotenze. Deve, ancora, solidarizzare con coloro che fanno doverose proteste: obiezione di coscienza, marce per la pace, giudizi contro l’illegalità delle spese militari. Deve combattere l’autoritarismo, le molteplici forme di violenza, la chiusura ideologica. La Chiesa deve rendersi sempre più consapevole che l’esaltazione dei condottieri, il disprezzo per i vinti, il culto della razza, la glorificazione della patria, l’eurocentrismo, non sono virtù per l’uomo del villaggio globale. La denuncia delle inadempienze radicali degli uomini e delle intollerabili povertà di certe categorie sociali non è sufficiente. È necessario che la Chiesa difenda i diritti e le attese dei poveri e dei bisognosi, intervenendo nelle forme più attente ed efficaci. Gesù con la ‘moltiplicazione dei pani e dei pesci’ nutre gratuitamente le folle e le fa vivere di speranza. Senza chiedere nulla in cambio. È un messaggio evangelico chiaro e inequivocabile che, anche dopo duemila anni, ci ricorda che la Chiesa o è carità o è falsità; e che la Chiesa è sempre e solo amore per la gente. Tutto questo significa fare anche politica».
OLR La Chiesa deve guardare alla politica nel senso più alto e nobile del termine, ma non all’«unità politica dei cattolici». Lei lo ha detto più volte ed è stato attaccato anche per questo.
RN «Sì, la Chiesa deve certamente guardare alla politica in senso generale,
non a un solo partito. E sempre in difesa dell’uomo, mai per i propri
interessi. L’ho scritto diverse volte sul settimanale diocesano ‘Caserta
Sette’ in occasione di scadenze elettorali. In sostanza, ho sempre sostenuto
che se la Chiesa mostrasse di preferire un solo partito lascerebbe perplesso
tutto il popolo di Dio. Un monolitismo politico non potrebbe mai tradurre,
né rappresentare la libertà della Chiesa. A molte persone fa comodo pensare
che basti essere iscritti a un partito che, magari, si autoproclami cattolico
per appartenere alla Chiesa cattolica. L’eventuale predilezione della
Chiesa per un partito politico genera nei credenti l’abitudine a considerare
la religione in termini ideologici e opportunistici. In questo modo si
potrebbe andare incontro alla pericolosa abitudine di pensare di salvaguardare
i valori religiosi mediante transazioni con il potere politico costituito,
usando la norma giuridica per sostenere ciò che vacilla nella coscienza,
preferendo l’ossequio formale alle spinte della libertà interiore. In
nome di un partito unico il credente facilmente diventa il portatore di
interessi di parte precisi e concordati, sostituendo la sua innovativa
qualità di cristiano per vocazione a quella, mortificante, di cristiano
per mestiere. I fedeli in Cristo, al contrario, devono essere sempre consapevoli
del grande valore rappresentato dalla libertà e dalla sincerità di coscienza
e che essere missionari oggi non significa essere partigiani».