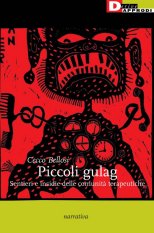Cecco Bellosi
Piccoli gulag
Sentieri e insidie delle comunità terapeutiche
Editore Derive Approdi
pp. 176
Prezzo: Euro 14,00
Isbn: 88-88738-31-2
Le storie professionali di Cecco sono così dentro la sua vita
individuale, la sua "tecnica" della relazione è così
dentro la sua esperienza del vivere, dentro il suo sguardo mai conformista,
sempre posizionato dalla parte di chi non ha diritti, ironico, partecipe
eppure leggero, da darci il senso forte di una libertà: la libertà
– nonostante e oltre un contesto nemico e duro – di praticare
la propria differenza, di non doversi alleare né con il prete né
con il medico, di non doversi arrendere alla spartizione del corpo del
tossico tra paradigma della malattia e paradigma della morale. La libertà
di vedere il volto dell’altro, di non scarnificarlo, di non negarlo,
nemmeno con la scusa della guarigione dal dolore. La libertà di
trovare nelle pieghe di ogni esistenza, anche la più dura e la
più disperata, la parola della ribellione, della soggettività,
dell’individualità irripetibile. La libertà di affermare
con le proprie pratiche che ribellione, soggettività e individualità
non vanno "curate", "guarite", piegate.
Chi parla di rispetto per la persona – e lo fanno tutti, nel lavoro
sociale, ma davvero tutti, anche gli aguzzini – senza riconoscere
il suo diritto alla ribellione, non fa che recitare una giaculatoria vuota,
mendace.
E chi non ricorda la propria, di ribellione – o peggio, non ne ha
mai conosciuto la felicità inebriante insieme allo smarrimento
e ai prezzi da pagare – non sa lavorare per quella degli altri.
Susanna Ronconi
Quasi nessuno di quanti fanno il mestiere di Cecco è culturalmente
e umanamente egualmente capace di negare ogni distanza tra sé e
l’altro, tra l’operatore e l’"utente" come
i racconti in queste pagine dimostrano. In un mondo di "professionisti
della solidarietà" spesso ripiegato e rinchiuso su se stesso,
con figure di riferimento mai soggette a ricambio, a elezione e verifica
o sia pure solo a sollecitazione critica, che si relazionano sempre e
solo ex cathedra, quella di Cecco è una preziosa testimonianza.
Sergio Segio
"Il carcere è luogo delle privazioni e del controllo. La
comunità è luogo del controllo e delle privazioni. Entrambi
territori dell’imposizione, non sono però la stessa cosa.
La galera costringe all’ozio forzato, la comunità al suo
contrario: il lavoro forzato, anche nei confronti di se stessi. Il carcere
è così fuori dal tempo da essere maledettamente attuale;
la comunità è talmente ripiegata sul qui e ora da legare
le proprie radici vischiose a un passato remoto."
"Le comunità rappresentano un punto di ibrido incontro tra
etica religiosa e spirito del socialismo reale. L’etica religiosa
si esprime nell’assoluto della regola, lo spirito rieducativo nelle
frementi ansie di adeguamento alla norma, attraverso percorsi di riabilitazione
sociale. Le comunità terapeutiche sono in generale un formicaio
frenetico, nelle ore dedicate al lavoro ma anche in quelle di non lavoro.
Fluisce un attivismo sconosciuto alle prigioni: questo non significa che
vi scorra attività. Sedute di psicoterapia, preghiere, corsi di
formazione o di ginnastica, riflessioni guidate, momenti ricreativi riempiono
le persone di informazioni e convinzioni senza, di contro, ascoltare nulla.
Si svolge un condizionamento operante che, nelle intenzioni, dovrebbe
poi proseguire all’esterno, come una sveglia capace di mantenere
a lungo la carica."
"A parte la divisa, che cosa differenzia un operatore di comunità
da un agente di custodia? Il secondo è un carceriere del corpo,
il primo lo è dell’anima: a volte, di tutti e due."
Cecco Bellosi (Isola Comacina, 1948), da quindici anni si occupa di persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Attualmente è il coordinatore di comunità e case alloggio per uomini e donne malati di Aids. Nel 1991 è stato tra i soci fondatori della Lila (la Lega italiana per la lotta all’Aids). Ha collaborato all’Annuario sociale e al Rapporto sui diritti globali 2003 (Edizioni Ediesse).
Il testo
Chi ha detto che i tossici sono dei fannulloni, incapaci di riempire il
tempo? Che lavorino in proprio, rubando, o con regolare libretto, la loro
vita è appesa a una produttività frenetica. Stakanov, al
confronto, non era nessuno.
I tossici faticano come formiche, mentre consumano come cicale. Per un’estate
che dura poche ore: poi, la clessidra rovesciata torna a scandire obblighi
e fretta.
Brescia, primavera 1980.
Il carcere di Canton Mombello al solito stava scoppiando: non di salute
ma di detenuti. Le due sezioni si riempirono di drogati che pagavano il
contributo periodico alla voglia di marciapiedi puliti. Il fiume, straripando,
giunse a lambire la nostra cella. L’abitavamo in tre, un cubicolo
di dieci metri quadrati: teoricamente si apriva la possibilità
di un altro castello. Uno stendipanni pieno, senza vuoti di bucato.
La cortese ipocrisia del brigadiere nasceva dal bisogno: "So che
lo spazio è piccolo, ma vi dispiace aggiungere un letto? Altrimenti
devo mandare questo ragazzo ai topi…". Ad altri l’avrebbe
imposto con metodi bruschi, nei nostri confronti si mostrava gentile.
Sapeva già che non avremmo detto di no e non sapeva ancora che
avevamo perso.
Il ragazzo era pallido, percorso da brividi, sudava freddo. Per cinque
notti non ci lasciò dormire, saltava su e giù dal castello
come un grillo impazzito. Sopportavamo, ci incazzavamo, imprecavamo.
Ma si capiva che stava male: non conoscevo l’astinenza, la vedevo
in atto. Gli davano valium solo dopo le nostre insistenze; quando lo chiedeva
lui gli ridevano in faccia. La cura era generalmente diversa, in quel
periodo; nel carcere di San Donnino massacrarono un ragazzo a calci nella
pancia: voleva una pastiglia, lo mandarono al creatore.
All’aria di Canton Mombello i tossici non esistevano. Sdraiati in
un angolo, si spostavano lentamente alla ricerca del sole come una mandria
svogliata di lucertole. Scheletri barcollanti si trasformavano in poco
tempo in lenti pachidermi. Potere dimagrante dell’eroina, potere
bulimico della pastasciutta. Guardandoli nella metamorfosi, trovavo strano
che nessun pubblicitario avesse ancora lanciato una linea dietetica: una
pera al giorno leva il grasso di torno. Meno costosa delle improbabili
cliniche della salute, più attraente delle insipide paste integrali,
e dai risultati efficaci.
Nessuno dei tossici passeggiava con gli altri detenuti, divisi in bande
rivali; a volte qualcuno veniva ammesso alle partite di calcio. Solo quelli
che giocavano bene, però: come per i negri valeva il criterio di
merito. Invisibili, salvo quando agivano gesti di autolesionismo. Un disperato,
in mezzo al cortile, cominciò un giorno a tagliarsi le vene: il
piccolo boss di turno lo rimproverò perché queste cose non
si fanno davanti a tutti.
Andrea non era invisibile: viveva con noi venti ore al giorno. Raccontava
del Carmine, popolare Bronx bresciano, e degli sbattimenti quotidiani.
Per farsi, doveva prima fare due, tre, quattro autoradio: dipendeva dalla
qualità, i ricettatori esibivano una competenza da Scuola Radio
Elettra.
Come i ladri di Marx (Carlo), i tossici non si limitano ad accrescere
il consumo: danno il loro obolo alla produzione. Andrea era ai limiti
dello sfinimento: lo trovarono, addormentato, su una macchina rubata.
Il carcere diventò per lui un momento di riposo, dove potersi ripigliare.
Come alle terme di Montecatini, dove uno va a fare per una settimana la
cura dell’acqua dopo 51 settimane dedicate al vino.
All’aria andava poco, come atto di presenza nell’angolo dei
fantasmi. Dovevano ricordarsi di lui, al momento del carico. Una volta
alla settimana un sorriso ebete si stampava sui loro volti: i cavalli
avevano portato la roba.
La sera raramente veniva in socialità con noi. Dalle sei alle otto
si poteva uscire a cena: andavamo nella cella dei bergamaschi. Questa
abitudine ci aveva procurato qualche fastidio; il clan dei calabresi aveva
letto la frequentazione come un’alleanza per il controllo del carcere:
quel piccolo potere che fa molto via Pal per la posta in gioco ma che,
per la sua irrilevanza, rischia quotidianamente di assumere toni drammatici.
Salvo nei casi di suicidio, le tragedie in carcere non accadono mai per
motivi seri.
Dei bergamaschi ci piaceva la cucina, ma non volevamo litigare per il
peperoncino. Una domenica andammo a pranzo dai calabresi, infilando come
gli anelli di una corona d’aglio una gaffe dopo l’altra: ci
presentammo con i pantaloni corti, ci sedemmo a tavola prima del capobastone,
versammo il caffè con la mano sinistra perché la caraffa
girava in senso contrario. Gesti al limite dell’insulto, ci dissero
poi, per il rituale; capirono però che non avevamo nulla contro
di loro.
Dei bergamaschi non amavamo solo la cucina, ma anche la genuinità
spaccona di banditi senza tempo: ci appariva più intrigante del
rapporto formale con una associazione gerarchica, sia pure a delinquere.
Chiamavano gli altri mandarini. Non si trattava tanto di una definizione
etnica a sfondo razzista, quanto del tentativo di connotare con puntuale
sarcasmo caratteri burocratici e lingua in codice dei clan meridionali.
La terra bergamasca è fertile di relazioni forti e di cantieri;
produce cottimisti della cazzuola e del prelievo: non a caso usavano le
ruspe anche per assaltare le banche e chiamavano lavori le rapine. Il
sabato sera, la cena delle valli aveva una carta d’obbligo: polenta
e coniglio. La tradizione, conosciuta, non gioca scherzi. Una volta la
donna del più raffinato della banda aveva portato col pacco un
vasetto di caviale; uno dei suoi compagni lo buttò dalla finestra:
pensava fosse tonno andato a male. Almeno con il coniglio non si correvano
rischi.
Andrea, quel sabato, non venne con noi. Disse che non aveva fame. Quando
tornammo in cella ci assalì la voglia di dolce: la privazione esalta
i piccoli piaceri. Al colloquio, mi avevano portato una forma di Toblerone.
Cercai il cioccolato sul ripiano che separa le due file di sbarre della
bocca di lupo, il frigorifero delle stagioni fresche e fredde. Chiesi
ad Andrea se sapeva che fine avesse fatto; aprì la bocca ma non
riuscì a parlare perché era piena di una poltiglia marrone:
l’aveva mangiato tutto. Il mattino seguente, al ritorno dall’aria,
decidemmo di preparare la pastasciutta, ma il formaggio grana era sparito;
Andrea, rimasto di nuovo in cella da solo, si era fatto: questa volta
di parmigiano.
Oltre la rabbia, mi apparve del tutto evidente una cosa: i tossici, di
là, finiscono nel girone dei golosi.
Non mi sono mai affrancato da questa convinzione: nei primi giorni di
comunità sgranavo gli occhi di fronte alle montagne di spaghetti
riversate nei piatti, vedevo le ragazze trasformarsi da aringhe in balene
bianche; ancora oggi rimango turbato dal caffè zuccherato da uno
di loro: i cioccolatini, al confronto, si fanno rimpiangere per un sano,
amaro gusto. Mi è capitato di parlare di queste abitudini con uno
psicologo, ricco di una delle mille teorie sulle ragioni della tossicomania:
mi ha risposto con ovvietà saputa che si tratta di una forma di
compensazione.
Bene, ma non ho mai visto compensare le abitudini di un cavallo con quelle
di una gallina: al massimo, con quelle di un mulo.
L’eroina è la regina dei golosi: mangiarne troppa fa star
male, né più né meno del cioccolato, del vino o del
sesso. A San Donnino dissero un giorno a Silvio che la noce moscata provocava
sensazioni allucinogene; per essere sicuro dell’effetto ne ingoiò
tre: rimase una settimana sul water. Lo psicanalista ci dirà compìto
che l’origine del disturbo è da ricercare lontano nel tempo,
nei conflitti della fase orale. Ma i sette vizi capitali esistevano senza
sentire la mancanza di Freud: facevano parte del patrimonio dell’umanità
ben prima della scoperta della nostalgia di un capezzolo.